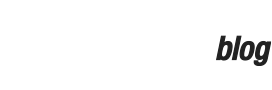Il sisma che ha colpito il Myanmar ha registrato gravi danni a edifici, templi buddisti, infrastrutture e, soprattutto, un alto numero di vittime. Un disastro frutto della combinazione tra fattori ambientali e vulnerabilità strutturale
Con una magnitudo di 7.7, il terremoto in Myanmar del 28 marzo 2025 ha causato oltre 3.300 vittime e centinaia di dispersi. Un’analisi condotta dalla Microsoft, riportata dal Post, ha calcolato che più di 515 edifici sono stati danneggiati per oltre 80% e altri 1.524 riportano danni tra il 20% e l’80%.
Il sisma è stato registrato alle 12:50 ora locale (7:20 in Italia) a 30 km a ovest da Mandalay, la seconda città più popolosa del Paese. La forte scossa si è fatta sentire anche in India, Bangladesh e Thailandia e qui ha provocato persino il crollo di un grattacielo in costruzione a Bangkok, lontana oltre 1.000 km dall’epicentro.
Per dare un’idea, il terremoto in Myanmar è stato 300 volte più forte di quello di Amatrice del 2016 (M 6.0) e ha superato di 44.700 punti la scossa nei Campi Flegrei di marzo 2025 (M 4.6). Ricordiamo che la magnitudo misura su una scala logaritmica (la scala Richter) la quantità di energia liberata dal sisma all’ipocentro della Terra, dove si verifica la rottura delle faglie. Ogni punto decimale di magnitudo corrisponde quindi a un incremento di energia di circa 30 volte.
I risultati disastrosi del sisma sono frutto di un insieme di fattori: l’oggettiva potenza del terremoto, le caratteristiche geografiche dell’area e, non ultima, la scarsa consapevolezza del rischio sismico. Vediamole in dettaglio.
La faglia di Sagaing
Il Myanmar è un’area ad alto pericolo sismico e ha già osservato, negli scorsi decenni, degli eventi simili a quello del 28 marzo. Come ha spiegato il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni, nelle parole riportate da SkyTG24, “nel secolo scorso ci sono state parecchie scosse di magnitudo superiore a 7: in soli 26 anni, dal 1930 al 1956, ce ne sono state 6 di magnitudo superiore a 7, quindi è un terremoto del tutto atteso in quell’area”.
Ciò accade perché in questo Paese è localizzata una delle faglie attive più pericolose del Sud-Est asiatico, quella di Sagaing. Il Myanmar si trova infatti in una zona di scontro tra due grandi placche tettoniche, quella indiana e quella euroasiatica, che si muovono di circa 5 centimetri l’anno. A queste si aggiungono anche i movimenti della placca di Sunda e della microplacca di Burma.
Un dettagliato studio dell’INGV ha analizzato la porzione della faglia di Sagaing attivata dal terremoto. La rottura lungo la faglia si è propagata in circa 90 secondi e da lì, poi, ha proseguito verso sud a una velocità molto elevata. Il sisma avrebbe originato quello che nel linguaggio tecnico si chiama “evento supershear”, ovvero una grande onda d’urto in cui si sovrappongono una serie di onde provenienti da diversi momenti di rottura.
Il fenomeno, però, non sembra sufficiente a spiegare come mai il sisma sia stato avvertito anche a Bangkok. In questo caso entra infatti in gioco un’altra dinamica: la liquefazione del terreno.
L’effetto sabbie mobili
Dopo un terremoto, la liquefazione può verificarsi quando il terreno perde coesione e si comporta come un fluido. In questo modo si annulla la resistenza al taglio del suolo e il peso dell’edificio non è più sorretto adeguatamente. Poiché la superficie non riesce a rispondere alla spinta verso il basso, la struttura affonda o addirittura si ribalta.
Questo processo si accompagna a fenomeni di amplificazione del terreno. Le onde sismiche possono infatti viaggiare anche a lunghe distanze dall’epicentro e poi rivelarsi in superficie in base all’assetto stratigrafico delle rocce e dei terreni. La liquefazione riguarda infatti i substrati sabbiosi o i terreni limacciosi. In Italia, per esempio, si è osservata dopo il terremoto in Emilia-Romagna nel 2012.

Nel caso di Bangkok, la città sorge su un bacino alluvionale con sedimenti sciolti. Questo avrebbe amplificato le onde sismiche provenienti dal Myanmar, provocando delle oscillazioni in superficie abbastanza forti da far cedere quel grattacielo di 30 piani.
La prevenzione come miglior difesa possibile
Come ha ricordato su Ediltecnico Mario Tozzi, esperto geologo, il rischio del terremoto in Myanmar è stato accresciuto dall’assenza di una pianificazione territoriale accorta e di una progettazione antisismica. Non si scelgono materiali idonei, non si procede alla zonazione sismica e si dimenticano gli eventi sismici del passato.
La liquefazione del terreno è difficile da prevedere, ma è comunque possibile mappare le aree a rischio e impiegare tecniche costruttive che ne limitano gli effetti. Questo richiede investimenti in geologia, ingegneria del suolo e pianificazione a lungo termine.
Per ridurre il rischio si applicano delle strategie di miglioramento. Ad esempio, si interviene con la compattazione dinamica, ovvero un aumento della densità del suolo attraverso delle vibrazioni meccaniche. Poi si procede con il drenaggio delle acque sotterranee, per ridurre la pressione interstiziale. Infine, si impiegano materiali stabilizzanti per miscelare il suolo con agenti consolidanti e aumentarne la resistenza.
Il terremoto in Myanmar è un tragico promemoria di quanto il rischio sismico non possa essere ignorato. Di fronte a eventi di questa portata, la differenza tra una catastrofe e un impatto gestibile è determinata dalla prevenzione. Certamente non possiamo controllare le faglie né fermare i movimenti delle placche tettoniche, ma possiamo e dobbiamo costruire in modo consapevole.
Questo significa anche diffondere una cultura del rischio. Ogni passo verso una maggiore resilienza sismica è un investimento sulla sicurezza collettiva verso un futuro migliore.
Fonti:
- Ediltecnico, “Terremoto del Myanmar: un micidiale mix tra mancata cultura antisismica ed effetti di sito” di Alessandro Grazzini;
- INGV Terremoti, “Risultati preliminari sulla faglia di Sagaing in Myanmar, terremoto M 7.7 del 28 marzo 2025”;
- Geopop, “Come ha fatto a crollare un grattacielo a 1000 km dal terremoto del Myanmar?” di Stefano Gandelli;
- SkyTG24, “Terremoto Myanmar e Thailandia, perché c’è il rischio di liquefazione del terreno”.